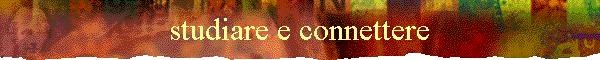Introduzione
Per Bartlett1
il pensare è una necessità derivante dal fatto che l’informazione di fronte a
cui ci troviamo è spesso incompleta, lacunosa e, però, noi abbiamo comunque una
qualche necessità di colmare questi vuoti per dare un senso alle cose o per
potere proseguire nel nostro cammino di vita.
Incontriamo, ad es.2,
qualcuno, poniamo un amico, dopo un certo periodo in cui non abbiamo avuto modo
di vederlo, e notiamo che il suo aspetto ed anche i suoi atteggiamenti sono
cambiati. Ci stupiamo e subito cominciamo a
pensare
a che cosa possa essere successo in questo
intervallo ed avanziamo delle ipotesi che riescano a spiegare in maniera più o
meno plausibile la trasformazione, basandoci sulle informazioni precedenti che
già avevamo e sulla conoscenza del suo carattere. Oppure prendiamo in prestito
un libro dalla biblioteca, ma purtroppo dopo averne iniziato la lettura ci
accorgiamo che manca una pagina. Cerchiamo allora di ipotizzare che cosa possa
contenere la pagina mancante, partendo da quanto riportato dall’ultima pagina
esistente e collegandoci con la pagina successiva3.
Il riflettere, in modo
più o meno stringente, somiglia in generale a qualcosa di questa fatta.
Per Bartlett4
il pensare è, però, classificabile secondo tre grandi tipologie:
l’interpolazione, l’estrapolazione e la
“manipolazione”,
se così possiamo dire.
Per quanto riguarda
l’interpolazione, i casi concreti citati sopra ne sono appunto
un’esemplificazione.
In modo più formale si
può affermare che l’interpolazione è necessaria tutte le volte in cui abbiamo un
vuoto in una catena di informazioni che si interrompe ad un certo punto,
presenta cioè un gap, per poi proseguire
regolarmente ed arrivare ad un suo punto di chiusura.
Esercizi di questo tipo
vengono svolti spesso a mo’ di gioco tutte le volte in cui ci si presenta, ad
es. in un giornaletto passatempo, una
serie di numeri (o di lettere, ecc.) che hanno
uno o più spazi bianchi al loro interno (cioè qualche numero, o lettera, sono
mancanti in seno a questa catena). Il compito del lettore, allora è quello di
individuare, dedurre una logica che
governa la serie fino al punto di interruzione e da lì fino alla sua fine.
Ad es. nella serie
semplicissima 2 4 .. 8 10, tramite un’operazione di interpolazione possiamo
facilmente prendere atto che la serie avanza, prima e dopo il gap, cioè il
numero mancante, di due unità alla volta, e ciò ci consente di dedurre che la
cifra “asportata” è il 6 e la catena
completa non potrà che essere 2 4 6 8 10.
La vita ci richiede
spesso delle operazioni di interpolazione.
Per ciò che attiene
all’estrapolazione, essa è indispensabile come attività mentale tutte le volte
in cui alcune informazioni vengono presentate, sono sviluppate fino ad un certo
stadio, ma poi la serie viene interrotta, abbandonata senza essere più ripresa.
In questo caso si tratta allora non solo di vedere come continuarla, ma di
individuarne anche il suo punto terminale, cioè l’arrivo.
Pure per quanto riguarda
tale modalità è necessario identificare delle norme che legano tra di loro le
unità presentate, come avveniva prima, solo che ora l’operazione è un po’ più
“aperta”, per così dire: da quest’unica sezione devo dedurre la continuazione ma
anche la sua naturale conclusione (e quindi specificare la “via” nella sua
completezza).
Mentre con
l’interpolazione in un certo senso le regole sono parimenti distribuite in due
porzioni di una catena ed è necessaria una doppia operazione, cioè prima
identificare e poi (o anche contemporaneamente) porre a confronto la
logica della prima parte della serie con quella della sua seconda sezione per
vedere se e come esse collimano, con l’estrapolazione il processo richiesto è
differente. I criteri risolutivi sono addensati da un lato solo ed è
indispensabile produrre ipotesi di continuazione e supposizioni riguardo
all’arrivo.
Forse nel primo caso
(l’interpolazione) è necessario un procedimento di pensiero che vada soprattutto
in parallelo, mentre nel secondo
caso (l’estrapolazione) è richiesto un processo principalmente seriale.
Un esempio di
estrapolazione è dato dallo stesso Bartlett5:
1234; 2134; 2143………….
Se sottoponessimo questa
serie composta da tre gruppi numerici alle persone, esse dovrebbero innanzitutto
trovare la probabile regola che lega gli insiemi dati tra di loro e quindi sulla
base della norma specificata riuscire a produrne altri, ma dovrebbero, anche,
decidere quando terminare la serie, cioè fino a che punto portarla avanti.
Nell’esempio riportato
la regola che lega il secondo gruppo al primo potrebbe essere che esso ha i
primi due numeri invertiti, mentre il terzo ha gli ultimi due numeri invertiti,
per cui ci dovremmo aspettare da una persona che abbia individuato tale criterio
la produzione del gruppo 2413, come quarta cifra, in quanto questa volta vengono
invertiti i due numeri di mezzo. Questa è appunto un’operazione tipica di
estrapolazione. Un problema a parte, che non merita di essere discusso qui,
è quando considerare terminata logicamente la serie (ad es., fino a quando
continuare l’inversione dei numeri a gruppi di due?).
Per quanto riguarda la
terza modalità, la “manipolativa”,
(come possiamo sinteticamente definirla) essa è quella che ha più a che vedere
con i processi della creatività.
Con questa denominazione
vengono indicati procedimenti di pensiero per situazioni che Bartlett6
differenzia in casi in cui tutta l’informazione necessaria è presente ma essa va
reinterpretata, va osservata da altri punti di vista più nuovi ed originali; ed
in circostanze in cui i dati necessari sono incompleti, lacunosi e, pertanto,
ulteriori ricerche ed esperimenti sono probabilmente indispensabili. Si pensi
per quest’ultima evenienza a tutto lo sviluppo scientifico fondato proprio
sull’aggiunta di nuove conoscenze al nostro patrimonio culturale.
Potremmo anche definire
le prime due modalità (l’interpolativa e l’estrapolativa) come
identificative e la terza (la “manipolativa”)
come produttiva.
Le lezioni CoRT
De Bono con le lezioni
CoRT7
ha messo a punto delle unità didattiche adatte a sviluppare pensiero delle tre
tipologie. Esse sono risultate efficaci8.
Il tentativo di
indirizzare e favorire i processi riflessivi viene reso possibile nella
filosofia di de Bono grazie all’impiego di “strumenti”.
Essi sono “organizzatori
mentali”, se così possiamo dire, che, avendo acquistato anche per l’uso di
nomignoli e sigle una dimensione di riconoscibilità, riescono concretamente a
dare ordine ad operazioni mentali altrimenti evanescenti e pertanto poco
educabili. I discenti vengono, perciò, aiutati in maniera determinata ed
allenati fattivamente a canalizzare la riflessione in una specifica direzione.
Ad es., quando ad uno
studente si richiede di svolgere un PMI (dove P sta per Più,
M sta per Meno ed I sta per Interessante- il
processo mentale riguardato è quello del giudizio) egli sa che deve
mettere in moto una ben precisa catena di operazioni in sequenza per potere
arrivare ad un giudizio fondato su contenuti “ricchi” piuttosto che sui propri
pregiudizi, su gusti passeggeri o, peggio, sull’aleatorietà. Egli si formerà
un’opinione solo attraverso una serie di passaggi intermedi che amplieranno le
sue capacità intellettive.
Ciò vale anche per
quanto riguarda le altre operazioni mentali.
Che possa verificarsi
tale arricchimento mentale è importante: tanti docenti frequentemente si
meravigliano di come certe osservazioni dei ragazzi siano superficiali. E questo
cozza con il proposito di creare una classe riflessiva,
la quale, del resto, è l’aspirazione profonda di tutti gli insegnanti ed il
punto di arrivo di ogni vero atto educativo.
Gli strumenti CoRT e le tre tipologie di
pensiero
Lo strumento dell’APC
(Alternatives, Possibilities, Choices) prepara, così, alla
“manipolazione”, per usare una delle tre categorie di cui sopra, insegna
operazioni di apertura al nuovo, alla creatività, trasmettendo le modalità che
possano portare ad embrioni di pensiero laterale9.
Viceversa il C&S
(Consequences & Sequels) allena gli studenti in forme di
pensiero estrapolativo (è la seconda delle tipologie di Bartlett),
affinché essi si abituino a calcolare le conseguenze di certe premesse o a
prevedere i risultati di determinate azioni poste in essere.
Il CAF (Consider
All Factors), invece, sviluppa nei discenti l’attenzione ai
fattori costituenti di una data situazione ed ai legami esistenti tra di loro,
ne affina la sensibilità perché essi non ne trascurino alcuno tra quelli, in
modo tale da potenziare le loro capacità interpolative (per usare la
terza delle categorie di Bartlett).
Questi sono alcuni tra
gli strumenti fondamentali offerti da de Bono.
Ma quali sono le
capacità riflessive medie dei discenti? In che misura nelle nostre scuole gli
studenti imparano a pensare? È possibile anche affermare che il pensare è un
sottoprodotto dello studiare?
In due studi precedenti
erano già state affrontate da me queste problematiche.
Nel primo di essi, “Studiare
e pensare”10,
erano state esaminate le possibilità “manipolative”
dei nostri allievi in un tipico contesto scolastico.
I risultati di questo
esperimento hanno dimostrato che alunni di 14-15 anni, invitati prima a studiare
due testi differenti (decodificabili in modi diversi, alcuni tra questi comunque
da classificarsi come più scontati ma più superficiali rispetto ad altri), e a
rispondere poi ad alcune domande scritte su entrambi, preferiscono aderire
strettamente al senso apparente di un brano piuttosto che tentarne una
reinterpretazione, anche quando ciò può sembrare necessario.
Diversi, invece, erano
stati i risultati, quando alcuni tra questi alunni erano stati invitati ad
utilizzare lo strumento APC (vedi le lezioni CoRT summenzionate)
nella loro opera di decodificazione dei testi. Il prodotto della loro
riflessione era stato allora variegato ed interessante.
Insomma lo studio, per
come è comunemente vissuto, di per sé non porta ad alcuna “manipolazione”, ad
alcun tentativo di vedere le cose da un punto di vista un po’ più originale e
differente.
Nella seconda ricerca, “Studiare
aiuta a pensare?”11
erano stati esaminati in senso lato i rapporti tra lo studiare, come
correntemente viene inteso nelle nostre scuole, e cioè come applicazione ad un
testo e ritenzione dei suoi contenuti, ed il pensare, il riflettere,
interpretati questa volta come capacità di “operare” sui contenuti, avendoli
compresi in pieno, cioè come possibilità di svilupparne le implicazioni nelle
direzioni più appropriate. Più concretamente si voleva vagliare le capacità di
alunni di 14-15 anni di svolgere pensiero proiettivo, ovvero, per usare la
terminologia di prima,
estrapolativo.
141 studenti erano
stati, così, assegnati a tre condizioni differenti, una delle quali era quella
dello “studio”. In questo caso (per brevità si omette la descrizione delle altre
due condizioni) essi avrebbero dovuto innanzitutto apprendere una storia
che non veniva comunque presentata nella sua interezza, ma era tagliata, per
così dire, a metà ed il resto tralasciato.
Dopo averla studiata
come abitualmente fanno quando hanno da ripetere determinati contenuti al
docente, essi avrebbero dovuto, poi, supporre, sulla base degli indizi esistenti
nella prima parte, la continuazione e la conclusione della storia, ovviamente
fondandosi sulla logica piuttosto che sulla fantasia.
La specifica novella
era stata scelta dopo un’attenta analisi dei suoi contenuti. Essa si prestava
particolarmente a questo esperimento: infatti, per la presenza di un congruo
numero di indizi sparsi nella parte della storia presentata ai discenti, un
attento e riflessivo lettore avrebbe potuto individuare in via di massima la
continuazione e la fine della vicenda.
Ebbene la condizione
dello studio è risultata, in maniera significativa, la peggiore delle tre per
quanto riguarda la previsione dell’epilogo, cioè l’operazione di
estrapolazione. Molti si sono abbandonati alla pura fantasia piuttosto che
fondarsi sui dati reali presenti oppure l’epilogo è stato scelto partendo da
quello che ognuno desiderava sarebbe successo dopo. Pochissimi, tra quelli
assegnati a tale condizione, sono riusciti nell’intento “estrapolativo”.
Anche in questo caso è
sembrato che studiare non si conciliasse alla perfezione con pensare.
Nei due studi
summenzionati è anche risultato non esserci nessuna sostanziale diversità, per
ciò che attiene alla capacità di compiere le operazioni richieste, tra ragazzi
di primo anno delle superiori (di 14 anni) e ragazzi di secondo anno (di 15
anni), né tra livelli di profitto.
La differenza era solo
determinata dalla condizione a cui gli studenti erano stati assegnati (ad es.,
studio soltanto oppure studio ed
utilizzo degli strumenti CoRT).
Abbiamo parlato di
manipolazione e di estrapolazione: sono forse le operazioni di
interpolazione più facili per i nostri alunni?
A tale riguardo è stata
organizzata la seguente ricerca.
La ricerca
Se definiamo
l’interpolazione come quella operazione che riesca ad esplorare in un insieme di
dati significativi in contemporanea le parti (due o più) di cui esso è composto
per scoprine la logica che le regge, la norma che le tiene unite, sopperendo
altresì eventuali dati mancanti, ovvero colmando i vuoti esistenti, allora non è
difficile organizzare uno studio su quest’altra tipologia di pensiero.
Dopo un’attenta analisi
dei contenuti di numerosi brani, è stato, infatti, scelto il racconto “Il
camaleonte”12
di Cechov, in quanto particolarmente adatto.
Tale novella è tutta
giocata sul filo dell’ironia, della satira di costume, che in nessuna parte,
però, della storia sono statuite esplicitamente come il tenore o l’obiettivo
della stessa.
Solo un lettore attento
che tenga presenti i diversi passaggi ed i mutamenti d’atteggiamento dei
personaggi, i quali avvengono in momenti differenti dell’enucleazione della
trama, può rinvenire il vero messaggio della novella.
Insomma l’alunno che
vuol comprendere pienamente e non superficialmente questa storia deve scoprire
quello che non è mai detto esplicitamente, ha da colmare vuoti
e può far ciò solo se riesce, per così dire, ad interpolare
le varie parti e le diverse transizioni.
La novella è stata,
pertanto, sottoposta a 77 frequentanti il primo ed il secondo anno dell’Istituto
Tecnico Commerciale “Besta” di Ragusa e a 19 studenti del secondo anno del Liceo
Linguistico “Vico” della stessa città, in un arco temporale compreso tra gennaio
ed aprile 2006.
I 96 alunni sono stati
assegnati ad un’unica condizione, quella dello studio,
in quanto si voleva semplicemente vedere che percentuale di studenti avrebbero
compreso la reale natura del brano e avrebbero formulato esplicitamente quello
che nel testo resta implicito.
D’altronde la
convinzione di partenza era che delle tre operazioni fondamentali di pensiero
l’interpolazione fosse la più semplice (vedi al riguardo anche Bartlett13).
Quest’unica
condizione di studio era in quanto tale
abbastanza simile a quella delle altre ricerche summenzionate: i discenti
avrebbero dovuto, nella prima di due ore, studiare il brano, per poi riassumerlo
nella seconda ora per iscritto, indicando in chiusura (e questa era l’ultima
consegna data) anche la “morale” della storia, l’essenza della vicenda.
Il racconto è stato
distribuito in edizione integrale, era stato asportato solo il titolo, in quanto
la definizione di “Camaleonte” poteva indubbiamente puntare al carattere della
trama.
Perché si possa
comprendere più concretamente la natura della prova, si danno di seguito una
sintesi ed alcuni estratti del racconto.
Breve sintesi del racconto
Il racconto parla del
commissario di polizia Ociumielov e di una guardia che lo segue la cui
attenzione è attirata da qualcuno che strilla mentre i due attraversano la
piazza del mercato.
A quanto pare un signore
è stato morso da un cane, lo si capisce dalle imprecazioni: infatti, subito
dopo, si scorge un uomo in camicia che rincorre un cane e successivamente
riesce a trattenerlo per le zampe posteriori.
Il commissario e la
guardia si avvicinano al luogo dello schiamazzo e vedono che l’orefice Chriukin
mostra alla folla, la quale nel frattempo si è lì radunata, un dito della mano
destra insanguinato. Accanto sta tutto tremante un cucciolo di levriero.
Il commissario chiede
che cosa sia mai successo.
“Io [……]-comincia
Chriukin [……]- sto parlando [……] con Mitri Mitric’, e tutt’a un tratto questo
vigliacco, che è che non è, mi morde il dito…Voi mi scuserete, io sono un uomo
che lavora. [……] Bisogna che mi indennizzino, perché io con questo dito forse
per una settimana non farò un movimento…”14.
Il commissario sembra
colpito da queste parole e convinto ad intraprendere un’azione investigativa: “Di
chi è il cane? Io non la lascerò così. Vi insegnerò a lasciar liberi i cani! È
ora di rivolger l’attenzione a simili signori che non vogliono sottostare alle
disposizioni!”15.
Ociumielov si rivolge
allora alla guardia, di nome Elderin, invitandolo a stendere il verbale
dell’accaduto, mentre aggiunge: “E il cane va soppresso. Senza indugio!
Di sicuro è arrabbiato… Di chi è il cane, domando?
- A quanto pare, è del generale Zigalov!- dice qualcuno
della folla.
- Del generale Zigalov? Uhm!….Toglimi un po’ il cappotto,
Elderin….Fa un caldo terribile! S’ha da supporre che stia per piovere…”16.
Il commissario a questo
punto comincia a fare domande incalzanti sulle modalità del morso e chiede come
sia potuto succedere che un cane così piccolo abbia azzannato al dito della mano
destra un uomo grande e grosso come Chriukin. Non è magari, si interroga ancora
il commissario, che l’orefice si è graffiato con un chiodino ed adesso vuole
dare la colpa al cane per spillare soldi al suo proprietario?
Qualcuno della folla
suggerisce che Chriukin abbia premuto il suo sigaro sul muso del cane e di
conseguenza ne è stato morso.
Ma la guardia ha ora
un’illuminazione, avanza un’osservazione suggerita dalla sua conoscenza delle
cose.
“Non è del
generale [……] Il generale di così non ne ha. Lui ha soprattutto dei cani da
fermo”17.
Allora anche al
commissario comincia a sembrare che il cane non possa essere di Zigalov, perché
lui ama solo i cani di razza ed il cane che ha morso non si capisce
completamente di che tipo di razza sia. Infatti Ociumielov dice:
“Né pelo né
figura….una cosa ignobile [……]. Se s’incontrasse un cane simile a Pietroburgo o
a Mosca, sapete che avverrebbe? Là non guarderebbero nella legge, ma sul
momento: muori! [……] È necessario dare una lezione! È ora
”18.
Però la guardia
sfortunatamente, imbeccato anche da qualcuno tra la folla, ha un ripensamento, è
preso dal dubbio che sia del generale; forse, dopo tutto, può anche essere suo.
Allora il commissario: “Uhm!…Mettimi
addosso, caro Eldirin, il cappotto…Tira un po’ di vento…Ho dei brividi”19.
In quel frangente passa
di lì il cuoco di Zigalov, per cui si può senz’altro chiedere direttamente a
lui. Il cuoco alla domanda specifica reagisce affermando che si erano fatti
venire una strana idea, in quanto di cani così a casa del generale non ce ne
erano mai stati.
Ociumielov reagisce
immediatamente: “E’ un cane randagio! [……] Sopprimerlo, ecco tutto”20.
Ma il cuoco, che evidentemente non aveva completato il discorso, subito dopo
aggiunge che il cane era però del fratello del generale!
Il commissario sembra
profondamente colpito dalla notizia che il fratello del generale era arrivato in
paese. È come se avesse voluto saperlo per tempo:
“E io nemmeno lo
sapevo! Così questo è il suo cagnolino? [……] il cagnuzzo non è male..”21.
La storia si chiude con
la folla che comincia a ridere di Chriukin e con le seguenti parole minacciose
di Ociumielov alla volta dell’orefice: “Arriverò ancora fino a te!”22.
Come si vede il
commissario cambia spesso atteggiamento sulla base delle ipotesi di appartenenza
del cane. Si può notare facilmente come il suo rigore sia massimo se viene
suggerito che il levriero sia di uno sconosciuto, ma ha un tono accondiscendente
quando la supposizione è che appartenga al generale.
In questa versione
abbreviata ovviamente cogliere i tratti fondamentali della vicenda e cavarne il
senso complessivo è facilitato dal fatto che tutti i mutamenti sono accostati e
ravvicinati (ed anche forse evidenziati), non proprio come avviene
nell’originale. Per cui, per cogliere compiutamente la portata del test, è
necessario leggere il racconto completo, a cui, quindi, si rimanda.
I risultati
La prova, contrariamente
alle aspettative, è risultata più difficile del previsto, almeno per un gruppo
specifico di ragazzi.
Si diceva che alla
ricerca hanno partecipato 96 alunni, così distribuiti: 66 erano frequentanti
prime classi (4, tutte dell’Istituto Tecnico Commerciale “Besta” di Ragusa) e 30
le seconde classi (11 appartenenti ad una classe del “Besta” e 19, invece, ad
una seconda del Liceo Linguistico “Vico” della stessa città).
Nella tabella 1
vengono riportati i dati, a seconda della classi di appartenenza (prime o
seconde).
Tabella 1
|
|
Classi
prime |
Classi
seconde |
Totali di riga |
|
Risposta errata
(gli elementi di satira non vengono colti) |
52 |
5 |
57 |
|
Risposta corretta
(gli elementi di satira sono colti)
|
14 |
25 |
39 |
|
Totali di colonna |
66 |
30 |
96 |
Nota sulla tabella 1:
L'analisi del chi quadrato sulla differenza tra
risposte corrette e risposte errate attraverso le due condizioni mostra che essa
è altamente significativa da un punto di vista statistico, X² (1, N= 96)=30,472,
p ‹ ,001, 2-sided.
Le tendenze sono state le stesse attraverso le
classi e gli istituti. Non ci sono, cioè, state differenze significative nei
trend di risposta tra gli studenti di primo anno delle varie classi (percentuali
egualmente alte di risposte errate) né tra gli alunni di secondo (la variazione
non solo di classe ma anche di istituto non alterava la capacità di produrre
riflessioni fondamentalmente azzeccate).
Quando è stato possibile i risultati dettagliati
dei test sono stati sottoposti agli insegnanti della classe specifica che
conoscevano i livelli di profitto e di abilità e avrebbero potuto apprezzarne
l’influenza. Complessivamente si può dire che la resa scolastica sembra non aver
giocato alcun ruolo.
Nelle classi in cui si è svolta la ricerca pochi
erano i ripetenti per potere svolgere un’analisi della funzione esercitata
dall’età anagrafica rispetto alla classe di iscrizione.
Riflessioni sui risultati e conclusioni
Se, come si può notare già a prima vista, gli
studenti delle prime classi hanno nella stragrande maggioranza sbagliato le loro
risposte, al contrario, gli alunni di seconda hanno saputo, in maniera
significativa, offrire riflessioni pertinenti ed acute, cogliendo la satira
sociale presente nella novella.
L’esame degli errori (a prescindere dall’età
dell’autore) risulta abbastanza interessante.
Chi sbaglia sembra fissare la sua attenzione solo su un
qualche passaggio del racconto, estrapolandolo da tutto il resto ed
ingigantendone l’importanza.
Alcuni affermano, ad es., che la morale del racconto è
che “non bisogna maltrattare gli animali”. Chi asserisce questo è rimasto
evidentemente colpito della parte in cui un tizio della folla afferma che
Chriukin ha premuto il sigaro sul naso del cane così, tanto per divertirsi.
Altri, invece, ne ricavano la convinzione che le
bugie hanno le gambe corte: probabilmente danno un’importanza decontestualizzata
alle parole, già citate, del commissario: “come ha potuto morderti? [……]Forse
che può arrivarti al dito?” e alla parte finale contenente la minaccia di
Ociumielov indirizzata all’orefice: “Arriverò ancora fino a te!”.
Non manca chi sostiene che a questo mondo ci sono tanti
bricconi e furfanti i quali vogliono scroccare soldi al prossimo, simulando
danni immaginari: certamente per questi studenti acquista un rilievo tutto
particolare il frangente (già citato) in cui il commissario si trova a dire: “Probabilmente
ti sei graffiato il dito con un chiodino, e poi t’è venuto in testa l’idea di
spillar quattrini.”
In tutti questi casi è mancata la capacità di
collegare tra di loro i vari piani del racconto per cavarne un senso
complessivo. Si può anche sospettare che l‘operazione interpolativa sia
intrinsecamente più difficile in molte situazioni rispetto all’estrapolativa: è
da supporre che ci sia un carico aggiuntivo per la memoria di lavoro, costretta
a tenere in registro in contemporanea le varie parti dell’insieme informativo
proposto, perché la mente possa poi coglierne la logica complessiva.
Le osservazioni errate degli studenti sono,
comunque, risultate abbastanza elementari: è come se di fronte alla difficoltà
del compito essi abbiano preferito rifugiarsi in sentimenti “semplici” ed in un
certo senso, tipici dell’infanzia: “la natura va rispettata”, “occorre amare gli
animali”, “non bisogna dire bugie”, “a questo mondo ci sono tanti furbacchioni
(e per fortuna che la giustizia li smaschera!)”, “chi commette imbrogli prima o
poi la paga”, ecc.
Indubbiamente nel determinare questo vistoso
gradino tra gli alunni di prima e quelli di seconda, un certo peso può
esercitarlo la ancora germinale esperienza di rapporti sociali da parte dei
quattordicenni, al di fuori della cerchia familiare, nel mare grande delle altre
formazioni sociali, e dei rapporti di potere, spesso profondamente ingiusti, che
regolano dette formazioni. Probabilmente una pratica più avvertita di questa
natura può, poi, aiutare a cogliere i nessi che legano i vari piani di un
racconto complesso come “Il camaleonte”, ponendo l’allievo in “zona di sviluppo
prossimale” (come direbbe Vygotsky).
E’ perciò possibile che gli alunni di seconda
siano stati aiutati da una migliore conoscenza della società nel produrre
osservazioni pertinenti sul “Camaleonte”, del genere: “purtroppo non tutti siamo
uguali”, “alcuni ancora oggi (come il commissario Ociumielov) sono banderuole al
vento, disposti a cambiare posizione a secondo di chi si trovano di fronte”,
“parecchi per paura sono sempre dalla parte del più forte”, “non sopporto le
ingiustizie della società”, ecc.
Comunque sia, i dati dimostrano che nel
passaggio dalla prima alla seconda classe si verifica un apprezzabile
cambiamento dal punto di vista logico-cognitivo, probabilmente stimolato anche
dalla crescita di esperienze sociali e culturali che nel frattempo si
determinano.
Pertanto, è importante che gli insegnanti siano
più sensibili a queste differenze di capacità e non attribuiscano le difficoltà
di comprensione a svogliatezza oppure a scarse abilità di base.
Studiare, anche quando viene svolto in maniera
appropriata, non significa automaticamente capire tutto, così come non induce
necessariamente riflessioni della stessa qualità di quelle di un adulto
avvertito.
Ed ancora: il pensare, come abbiamo visto,
spesso prescinde dai livelli di profitto e di abilità; ed esso non è neanche un
sottoprodotto naturale o una funzione dell’impegno scolastico. Anzi nelle
ricerche citate sopra si è anche visto che la condizione “normale” dello studio
non è nemmeno la più appropriata perché si sviluppi riflessività.
Servono altri strumenti ed un impegno specifico
in tale direzione.
Giuseppe
Tidona
Ragusa, estate 2006

1 Frederic Bartlett,
Thinking- An Experimental and Social Study, London, George Allen & Unwin
LTD, 1958, p. 20.
2 Frederic Bartlett, op. cit.,
p. 21.
3 Frederic Bartlett, op.
cit., p. 22.
4 Frederic Bartlett, op.
cit., p. 22.
5 Frederic Bartlett, op.
cit., p. 38.
6 Frederic Bartlett, op.
cit., p. 49 e p.97.
7 E. de Bono, CoRT Thinking,
Blandford, Dorset, Direct Education Services Limited, 1973-1975; vedi anche
de Bono, CoRT Thinking Program. Workcards and Teacher's Notes,
Chicago, Science Research Associates, 1987.
8
Vedi i miei resoconti "E' possibile migliorare la
creatività e la riflessività dei ragazzi?", in Dialogo, anno XXVI,
n.7, ottobre 2001, Modica, pp 1-9, e "Riflessività e creatività a scuola",
in Dialogo, anno XXVII, n. 7, ottobre 2002, Modica, pp.7-8.
9 E. de Bono, Lateral
Thinking, N.Y., Harper & Row, 1970.
10 G. Tidona, Thinking and Learning- The Results of an
Experiment, paper presentato alla Fifth International Conference on
Creative Thinking, organizzata a giugno del 2004 dall'Università di Malta.
La versione in italiano è consultabile nel sito:
http://www.itcbesta.it/Tidona.htm
11 G. Tidona, Is Studying Conducive to Tinking?, paper
accettato per la presentazione alla 12th International Conference on
Thinking in Melbourne, Australia (2005); anche in questo caso la versione in
italiano è consultabile nel sito citato sopra.
12 la novella Il camaleonte di Cechov è stata tratta
dall'antologia in adozione nelle classi dell’ITC “Besta” di Ragusa, cioè da
A. Mariotti, M. C. Sclafani, A. Stancanelli, Il libro arancione - dal
Rosso e dal Giallo, Firenze, D'Anna, 2001. Il testo di Cechov è a p.104
dell'antologia.
13 Frederic Bartlett, op.
cit., p.33.
14 dall’antologia citata, p.
105.
15 dall’antologia citata, p.
105.
16 dall’antologia citata, p.
105.
17 dall’antologia citata, p.
105.
18 dall’antologia citata, p.
106.
19 dall’antologia citata, p.
106.
20 dall’antologia citata, p.
106.
21 dall’antologia citata, p.
106.
22 dall’antologia citata, p.
106.